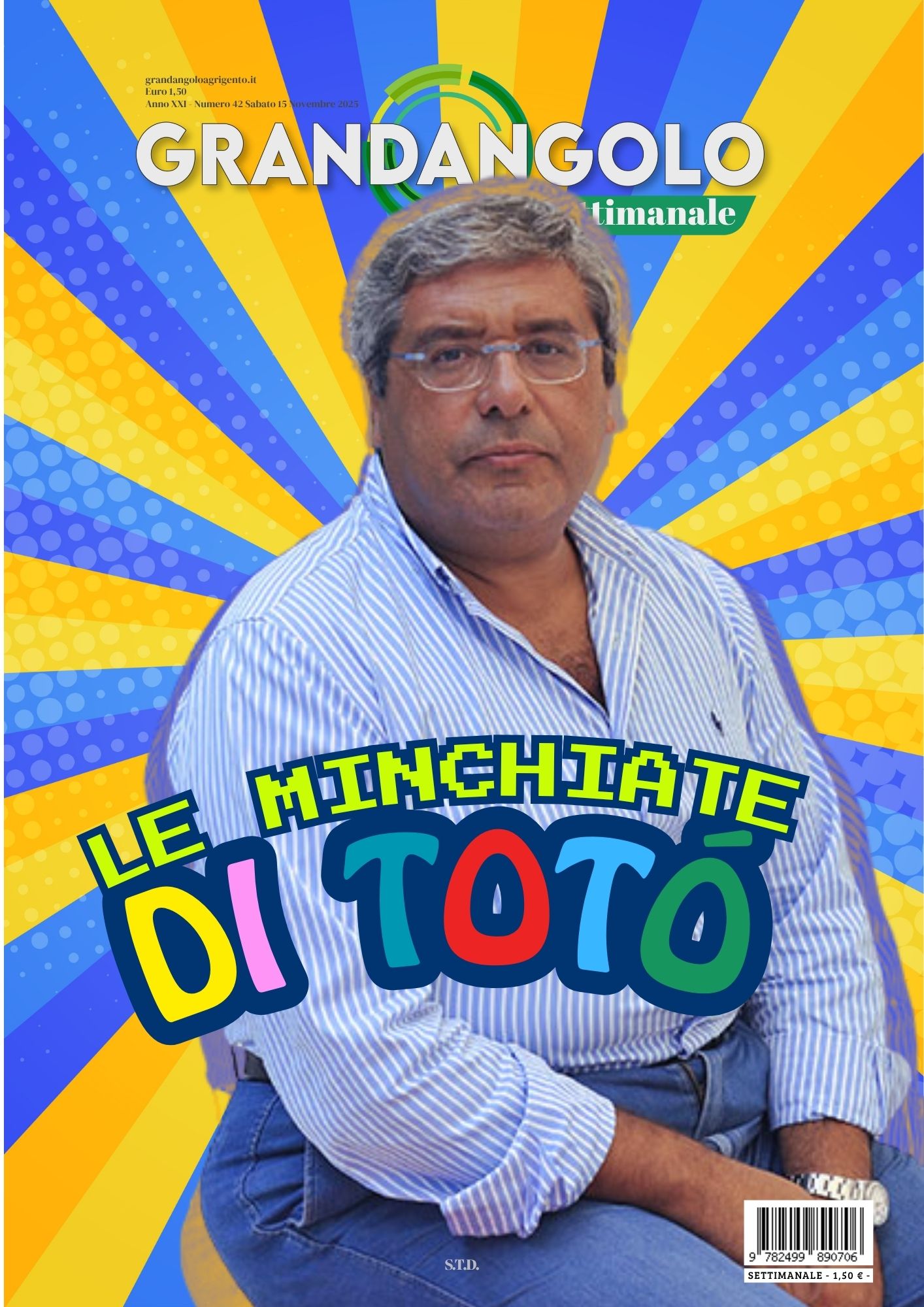Mafia, motivazioni processo Montagna: “Quaranta collaboratore attendibile”
Alla posizione di Quaranta, e al suo ruolo di collaboratore di giustizia, è stato dedicato un intero paragrafo nella sentenza di secondo grado
La seconda sezione penale della Corte di Appello di Palermo, presieduta dal giudice Fabio Marino, ha depositato le motivazioni della sentenza di secondo grado del maxi processo alla mafia della Montagna agrigentina. Il procedimento – conclusosi con 34 condanne, un solo “ribaltone” e diverse assoluzioni “pesanti”- scaturisce dall’omonima operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento eseguita nel gennaio 2018. La figura principale dell’intera inchiesta è Francesco Fragapane, figlio del boss ergastolano ed ex capo provinciale di Cosa Nostra Salvatore Fragapane, considerato dagli inquirenti il vero promotore del nuovo mandamento della Montagna: i giudici di secondo grado lo hanno condannato a 14 anni, riducendo la pena a venti anni di reclusione inflittagli in primo grado. Tra gli episodi di maggiore importanza verificatisi all’indomani del blitz c’è sicuramente l’avvio della collaborazione con la giustizia di Giuseppe Quaranta, netturbino di Favara, che per un periodo è stato il braccio destro proprio del boss Fragapane. Alla posizione di Quaranta, e al suo ruolo di collaboratore di giustizia, è stato dedicato un intero paragrafo nella sentenza di secondo grado.
Ecco cosa scrivono i giudici
“In questo paragrafo si affronta piuttosto la prerogativa di collaboratore attendibile del Quaranta. La prima osservazione da farsi riguarda il fatto che la Cosa Nostra agrigentina vivesse l’ennesimo momento di fibrillazione (una costante per la mafia di quelle lande) e che, il giovane Fragapane Francesco, dotato di natali mafiosi prestigiosi ed autorevoli, volesse approfittarne per rifondare e riorganizzare i mandamenti del territorio, secondo i propri desiderata. Per farlo, tra gli altri, aveva deciso, poco prima di dover varcare la soglia delle carceri per scontare dei residui di pena, di dare fiducia e mandato operativo a Quaranta Giuseppe, non un uomo d’onore di estrazione tradizionale, ma certamente un personaggio – almeno inizialmente – giudicato come capace e, soprattutto, spregiudicato. La cosa naturalmente non era andata a genio a tutti, ma nelle loro captazioni (come in quella da ultimo riportata nel riquadro) gli altri uomini d’onore organici (es. Valenti Stefano, Fanara Pasquale) non avevano potuto far altro che prendere atto dell’assenza di altri di loro – a parte il citato Quaranta – disposti a (o capaci di) mettersi a disposizione di Fragapane Francesco nel progetto riorganizzativo da costui vagheggiato . Quest’ultima notazione offre il destro per soffermarsi un momento sulla valutazione della personalità – e dunque, in definitiva, dell’attendibilità – del Quaranta, collaboratore di giustizia con ruolo di assoluto rilievo in questo processo, a suo tempo designato da Fragapane Francesco rappresentante della famiglia di Santa Elisabetta e, di fatto, riorganizzatore del mandamento. Il tema è importante, posto che le (processualmente legittime, ma francamente esagerate) censure difensive di larga parte dei gravami e, soprattutto, delle discussioni orali finali dei patroni degli imputati condannati per i delitti di cui ai capi A) e B) della rubrica, hanno provato a fare leva sull’ambiguità caratteriale del predetto e sulla sua (presunta) scarsa conoscenza delle dinamiche di Cosa Nostra in quei territori, per tentare di farne derivare automaticamente la sua scarsa credibilità dichiarativa. Sicuramente Quaranta non aveva un retroterra mafioso tradizionale di sangue, si era sempre mosso, piuttosto, nel mondo dei traffici illegali di stupefacenti, ma è indiscutibile – ed anche solo le pochissime captazioni fin qui riportate lo dimostrano – che fosse stato coinvolto da Fragapane Francesco nel detto progetto riorganizzativo e che avesse dunque piena e vissuta conoscenza di ciò di cui poi a lungo avrebbe parlato con l’Autorità Giudiziaria.
E’ anche vero – ma ciò rafforza, anzi che inficiarlo, il contesto di sostanziale attendibilità del collaboratore – che ad un certo punto lo stesso Fragapane Francesco si fosse reso conto di avere riposto male la fiducia accordata al Quaranta ed avesse veicolato, a fine luglio del 2014, dal carcere di Sulmona ove era detenuto, l’ordine di revoca degli incarichi dati all’odierno collaboratore, ma questo non vuol certo dire che Quaranta non avesse un patrimonio tale di conoscenze da non farne un dichiarante attendibile. Anzi, ad essere ragionevoli, significa l’esatto contrario. Che poi il collaboratore fosse una persona nel privato inaffidabile o di negativo contegno morale, francamente poco importa in una sede giudiziaria come questa, ove ciò che conta non è certo lo spessore etico dei protagonisti del giudizio o di chi abbia ritenuto di intraprendere un riscontrato percorso collaborativo (sempre ammesso, del resto, che i detrattori di Quaranta, già suoi sodali, abbiano essi stessi una intrinseca consapevolezza morale…), quanto invece la credibilità e riscontrabilità delle accuse mosse a terzi. Quel che è indiscutibile, al tirar delle somme, è che il collaboratore fosse ben addentro, e con ruolo verticistico almeno negli anni tra il 2014 ed il 2015-16, alle dinamiche di tipo organizzativo mafioso che costituiscono lo sfondo di questo processo. Pertanto non vi sono dubbi realmente sostenibili (e sul punto sono dunque condivisibili le articolate ricostruzioni che la sentenza di primo grado opera in proposito) sul fatto che Quaranta conoscesse bene i fatti che ha riferito nei vari interrogatori resi dopo il proprio arresto del gennaio 2018 e la quasi contestuale decisione di collaborare con la Giustizia. D’altra parte, sotto un profilo più squisitamente tecnico-processuale – introducendo alcune considerazioni che saranno meglio approfondite – il percorso collaborativo del dichiarante ha sempre obbedito ai requisiti che da sempre sono postulati dalla giurisprudenza di legittimità – a far data almeno da Sezioni Unite 1653 del 1993- affinché siano positivamente apprezzabili le contribuzioni di un collaboratore di giustizia. Ci si riferisce in primo luogo al nodo generale, ampiamente sciolto, della credibilità e consequenzialità del contesto dichiarativo, poi alla intrinseca consistenza e alle caratteristiche delle dichiarazioni del soggetto, infine all’esame dei così detti riscontri esterni, sempre puntualmente trovati ed evidenziati (vuoi nelle captazioni, vuoi nei pedinamenti, vuoi nelle varie situazioni che comunque saranno esaminate trattando dei singoli reati). La circostanza che su alcuni sporadici passaggi il dichiarante abbia avuto qualche ricordo impreciso non ne inficia certo la credibilità – caso mai la rafforza, essendo indice di mancanza di intenti platealmente calunniosi, del resto questi ultimi mai emersi in giudizio – essendo ciò inevitabile, quando si riempiono centinaia di pagine di dichiarazioni e di verbali ricostruttivi di anni di fatti di mafia. E’ davvero singolare – e seppur en passant va qui rimarcato – che l’argomento principale che le Difese appellanti hanno provato ad utilizzare per screditare il contributo accusatorio di Quaranta, risieda nel fatto che costui avesse letto, prima di rendere i propri interrogatori ai PM ai quali aveva iniziato a rapportarsi, l’ordinanza di custodia cautelare a carico suo e delle decine dei suoi coimputati. Francamente sfugge ilsenso di una censura di questo tipo. Ovviamente Quaranta, raggiunto dalla misura carceraria, aveva avuto (nel suo pieno diritto processuale), la propria copia del provvedimento restrittivo (…proprio perché la leggesse…) e sarebbe stato inusuale e – questa volta sì – poco credibile che non l’avesse letta, riletta, ponderata e fatta propria .Pertanto, che in taluni passaggi dei propri interrogatori il dichiarante abbia ribadito, parlando dei propri coimputati, dati e circostanze già note agli investigatori, e pertanto consacrati nell’ordinanza restrittiva, non fa di certo venir meno il contesto generale di attendibilità del collaboratore. L’argomento in parola, rinfocolato dall’impreciso ricordo di Quaranta – comprensibile visto il tempo frattanto trascorso – sulle circostanze esatte in cui egli avesse letto la prima volta l’ordinanza in questione, è veramente, sia detto con molto rispetto, fuori luogo.Esso pare una sorta di paralogismo fallace, per tramite del quale, da una situazione normale (e anche banale) si vuol provare, strumentalizzandola artatamente, a trarre spunti solidi di difesa. Quanto al fatto che il dichiarante non avesse grande fama di spessore etico, anche questo, in definitiva, ai fini della valutazione della sua credibilità rileva poco o nulla. Ad essere del tutto amorale piuttosto – a tacer d’ogni altra cosa – era tutto il sistema in cui Quaranta, secondo le iniziali volontà di Fragapane Francesco, era stato organicamente inserito con ruolo certo non marginale per anni (reggente della famiglia di Santa Elisabetta e riorganizzatore designato del mandamento), almeno fino a quando, per la riottosità del proprio carattere, perso un po’ del proprio smalto cooperativo, egli non aveva iniziato ad essere messo da parte proprio di colui il quale (cioè Fragapane Francesco, che frattanto stava soffrendo detenzione in Sulmona) per molto tempo lo aveva voluto, alle proprie dirette dipendenze gerarchiche, a farne le veci sul territorio. In ogni caso che Quaranta abbia sempre parlato, a ragion veduta, di cose che conosceva bene per averle vissute, risulta con chiarezza anche dagli scampoli delle captazioni che sono state riportate poco sopra, nel corso delle quali i parlanti Spoto, Nugara, Valenti Stefano e Fanara Pasquale, a parte manifestare livore verso il nostro (il che francamente non è certo un demerito), si davano reciprocamente atto della circostanza che comunque Quaranta fosse del tutto inserito nelle trame della Cosa Nostra agrigentina, proprio come il collaboratore aveva sin dall’inizio riferito agli investigatori. Tutto ciò precisato, ad ogni buon conto – questo va comunque detto come regola metodologica – nelle pagine a seguire in cui ci si soffermerà sui caratteri di individuazione e riscontro delle fattispecie di cui ai capi A) e della rubrica, le parole di Quaranta, ove rilevanti, saranno utilizzate in termini accusatori solo ove aliunde riscontrate, come è virtuosa regola di giudizio in casi del genere.”