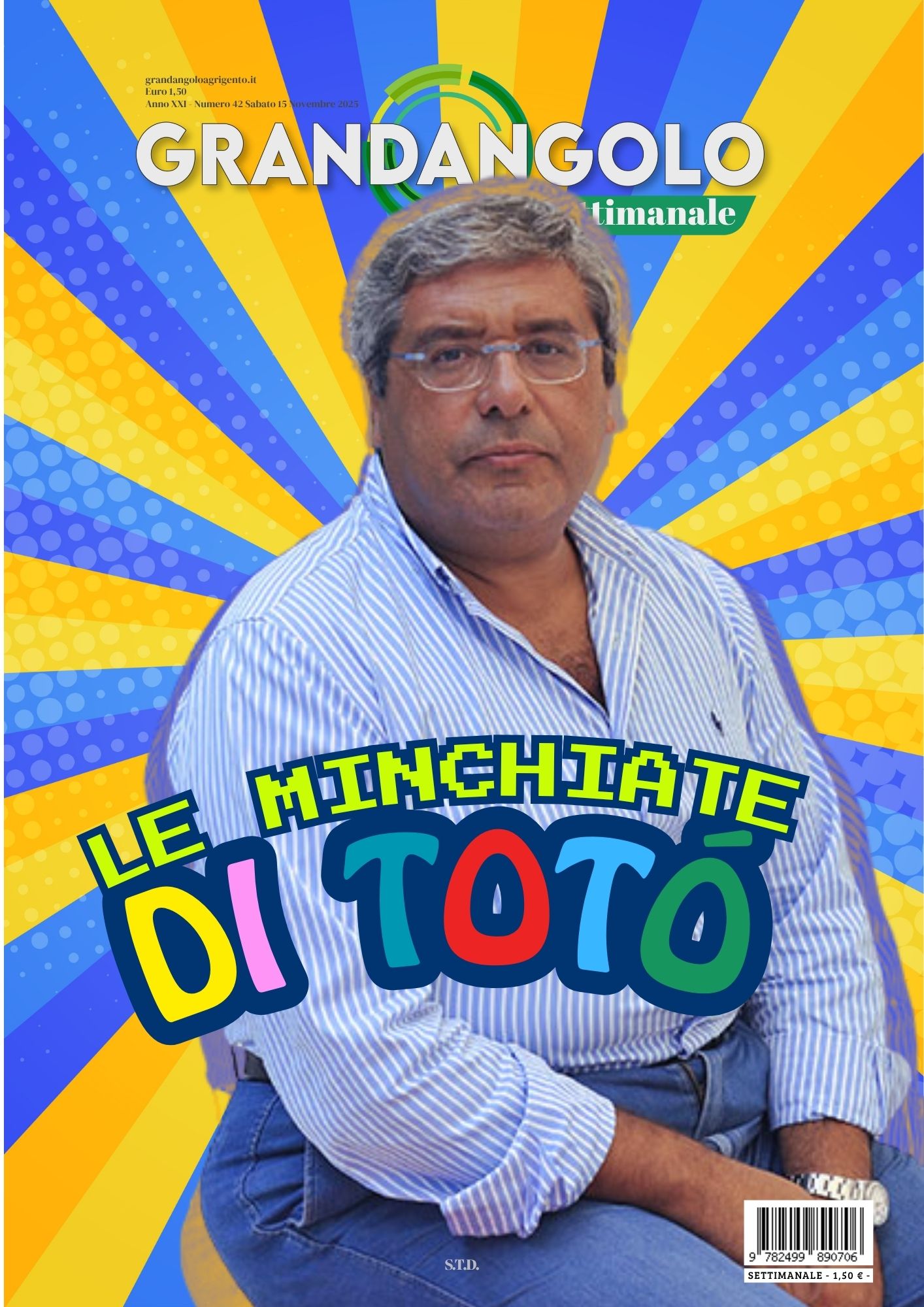Strage Ravanusa, mons. Damiano: “Tragedia che, forse, si poteva evitare”
Ennesima tragedia che un maggiore senso di responsabilità e un controllo più attento forse avrebbero potuto evitare.
Monsignor Alessandro Damiano ha celebrato i funerali solenni delle vittime della strage di Lampedusa pronunciando la seguente omelia:
«Si fece buio su tutta la terra»: dalle otto e mezza di sabato scorso, come dal mezzogiorno del venerdì santo. Si è fatto buio nella vita di Pietro e Carmela, Calogero, Liliana e il loro figlio Giuseppe, Angelo e Maria Crescenza, Giuseppe e Selene, a cui l’esplosione non ha dato scampo. Si è fatto buio nella vita di Samuele, che Selene avrebbe dato alla luce proprio in questi giorni e che, pur non avendo fatto in tempo a nascere, era già a pieno titolo uno di noi. Si è fatto buio nelle loro famiglie, che fino alla fine hanno sperato in un miracolo, o anche solo in una provvidenziale coincidenza, come quella che ha messo in salvo Rosa e Giuseppina. Si è fatto buio nella comunità di Ravanusa, che nell’esplosione, insieme ai suoi figli, ha perso un pezzo del suo spazio urbano e una traccia della sua memoria; ma ha perso anche la possibilità di sentirsi al sicuro, su un sottosuolo che si è dimostrato compromesso e dentro strutture che si sono rivelate precarie. Si è fatto buio nella comunità di Campobello, la comunità di Selene, dove lei abitava insieme al marito e al bambino che stavano aspettando e che avrebbe completato la loro famiglia appena costruita. E si è fatto buio nella nostra terra e nella nostra Chiesa di Agrigento, che nella solidarietà civile e nella carità cristiana si sono ritrovate come una grande famiglia, unita dalla stessa angoscia, dalla stessa speranza e dallo stesso dolore. Si è fatto buio anche nell’intero Paese, che ha seguito con apprensione le fasi di un’ennesima tragedia che un maggiore senso di responsabilità e un controllo più attento forse avrebbero potuto evitare.
In questo buio che tutti ci ha avvolti, anche noi — come le donne del Vangelo davanti alla pietra rimossa dal sepolcro e a quel corpo che non riuscivano a trovare — ci chiediamo che senso abbia tutto questo, se mai un senso ce l’abbia. Con voi e come voi, non ho una risposta a questa domanda. Ma, con voi e per voi, devo e voglio cercarla nella fede che oggi ci ha raccolti attorno all’altare del sacrificio di Cristo e attorno alla mensa della sua Parola di vita. A lui, che per rivelarci il mistero dell’amore di Dio ha voluto condividere la fragilità della nostra umanità, insieme vogliamo chiedere non la rassegnazione di fronte a una sconfitta inaccettabile, ma la speranza di una vittoria ancora possibile: per le dieci vittime di questa assurda tragedia, che vogliamo pensare nella ritrovata compagnia della vita eterna, e per tutti noi, che ancora dobbiamo fare i conti con la precarietà e le ambiguità della vita terrena.
Vogliamo fare nostro il cammino di Giobbe, il giusto provato ingiustamente, nel quale la domanda di senso di ogni uomo e di ogni donna trova la sua espressione più drammatica, ma anche il risvolto più inaspettato. Il cammino di Giobbe parte da un’esperienza simile alla nostra — la perdita di tutti e di tutto — e passa attraverso il dubbio lancinante finanche sulla bontà e sulla giustizia di Dio, arrivando addirittura a sfidare l’Onnipotente, perché anche i controsensi più assurdi dell’esistenza possano avere una risposta sensata. Questa risposta Giobbe la trova solo quando è disposto a riconciliarsi con quel senso del limite che — come ogni altro uomo — vorrebbe eludere, ma che non può in alcun modo eliminare. E così, dopo aver perso ogni certezza, insieme alla stessa voglia di continuare a vivere, non gli resta che un’ultima insopprimibile consapevolezza: tutto quello che è e tutto quello che ha, tutto quello che ha perso e tutto quello che ancora può avere, tutto quello che è capace di apprezzare e tutto quello che lo lascia indifferente, tutto è dono, sempre immeritato e sempre gratuito, sempre provvisorio e sempre sfuggente.
Dalla perdita di tutti e di tutto — e, in fondo, dalla perdita di se stesso — Giobbe impara che il limite non è una disgrazia, ma è la legge stessa della vita, che ci piaccia o no. E impara anche che il limite non toglie senso all’esistenza, ma le conferisce un significato più grande, perché solo se riconosciamo di essere limitati possiamo tendere verso un altro che ci completa: un altro che ha i nomi e i volti di persone concrete, alle quali a volte ci leghiamo e dalle quali altre volte preferiamo prendere le distanze; e un Altro il cui nome e il cui volto ci sfuggono, perché è infinitamente più grande di noi, dal quale riceviamo tutto e al quale tutto dobbiamo restituire, o quando è lui stesso a disporre della nostra vita e della nostra morte o quando — come in questo caso — con noi soffre per un incidente che neppure lui avrebbe voluto.
Solo quando raggiunge questa saggezza, Giobbe può dire ciò che abbiamo ascoltato nella prima lettura: «Io so che il mio redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!». Nonostante sia ancora troppo presto per arrivare alla sua stessa saggezza, anche noi vogliamo provare a balbettarlo: sappiamo che ultimo — dalle macerie di via Trilussa, come dalle tante macerie del mondo — non uscirà l’ultimo dei dispersi, ma Colui che dagli abissi della terra è risalito per mostrarci la via dei «cieli nuovi» e della «nuova terra»; il primo di una umanità riconciliata con il suo limite, che ci precede nella Gerusalemme nuova, dove — come san Paolo ci ha ricordato nella seconda lettura — niente «potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù». Allora anche per noi sarà «il primo giorno della settimana», l’inizio cioè di un tempo nuovo e di una storia diversa.
Ne abbiamo bisogno, oggi più che mai. Anzi, ne abbiamo il dovere. Lo dobbiamo a loro — a Pietro e Carmela, a Calogero, Liliana e Giuseppe, ad Angelo e Maria Crescenza, a Giuseppe, Selene e al loro Samuele — che abbiamo cercato tra i morti, ma che sono vivi in Colui che è «la risurrezione e la vita». Lo dobbiamo ai loro familiari e ai loro amici, che li hanno persi nella carne, ma che li possono ritrovare nella comunione dei santi. Lo dobbiamo a noi stessi, che da questa, come dalle tante tragedie della storia, dobbiamo rialzarci e riedificare — prima ancora delle case fatte di pietra — una città terrena sempre più vivibile e sempre più sicura, in attesa della città eterna dove Dio sarà «tutto in tutti». In particolare lo dobbiamo a quella creatura che, dal grembo materno divenuto tomba, ha visto la luce della risurrezione senza neppure vedere quella di questo mondo, ricordandoci — con la forza dei profeti che parlano con la vita, a volte senza pronunciare una sola parola — che non siamo fatti per la Gerusalemme di quaggiù, ma per quella che si compirà nell’eternità.
Quando avremo la grazia di capirlo o almeno di accettarlo — non da rassegnati, ma da uomini e donne capaci di speranza — dall’angoscia che ci opprime perché «si è fatto buio su tutta la terra» passeremo alla certezza che «la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta». E allora anche la notte più buia conoscerà l’aurora di un giorno che non avrà mai più fine.