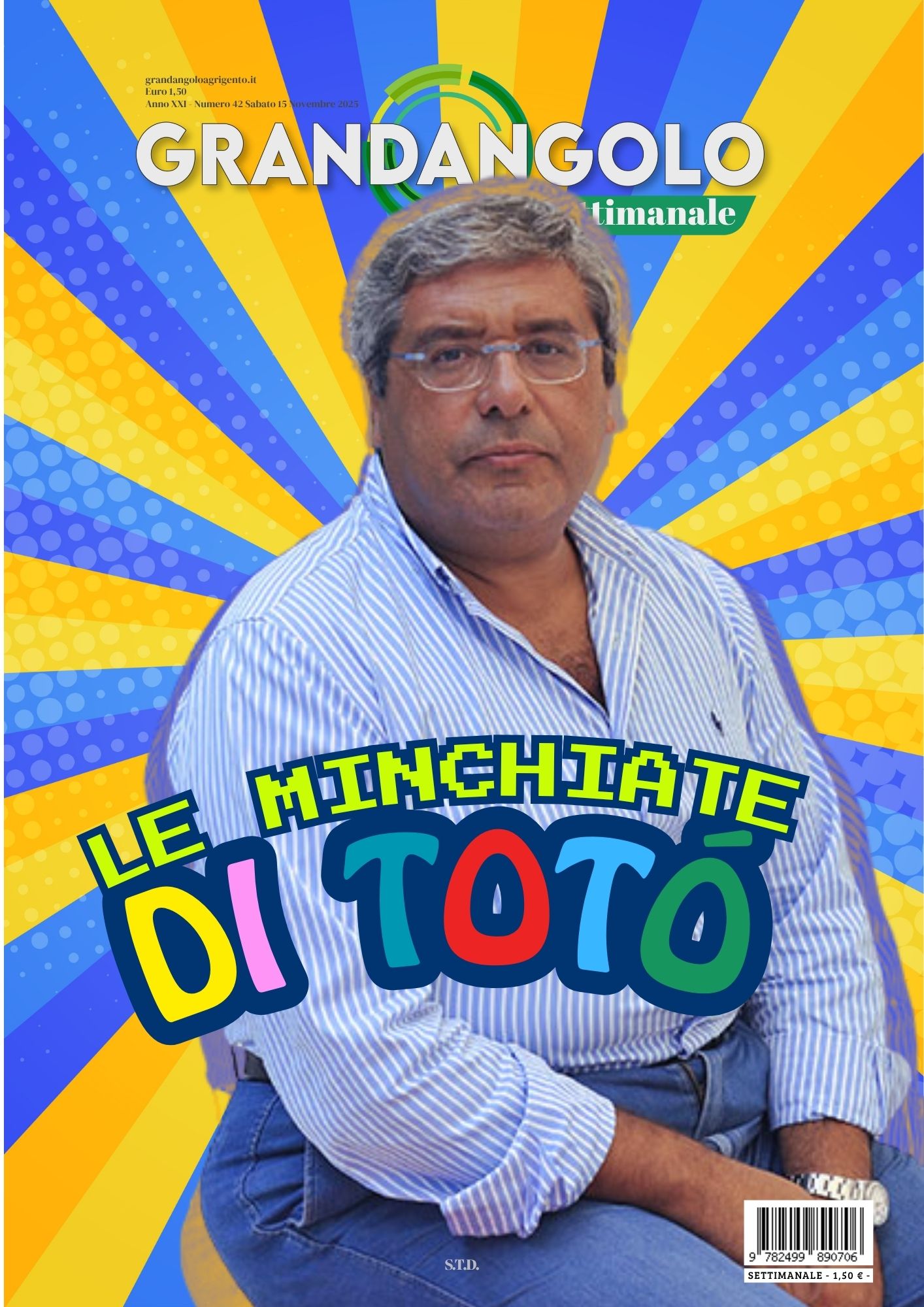Concluso il 75° Convegno Nazionale di Studio dei Giuristi Cattolici Italiani
Al centro del convegno il tema “Responsabilità e Giustizia nell’esperienza giuridica contemporanea”
Si è concluso ad Agrigento il 75esimo Convegno Nazionale di Studi dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, UGCI: sono stati giorni intensi che hanno visto partecipare, nella splendida cornice del Parco Archeologico di Agrigento, docenti universitari, studiosi, giuristi, personalità delle Istituzioni in una comune e polifonica riflessione sul tema “Responsabilità e Giustizia nell’esperienza giuridica contemporanea”. Ha aperto i lavori della seconda giornata, Alessandro Dagnino, Assessore Regionale per l’Economia che ha apprezzato l’occasione di riflessione su di un tema così importante offerto dall’UGCI ed ha commentato: “In particolare nell’ambito del governo regionale ci si propone costantemente di dare conto alla collettività, di dare riscontro, di offrire i risultati per i quali questi ruoli di governo sono occupati. Allora questi momenti di riflessione sono di rilevante importanza per chi si dedica in questi due giorni a riflettere non soltanto ad agire, sottraendosi per qualche momento dalla frenesia della quotidianità e degli impegni di governo”
Ripercorriamo i temi emersi attraverso le voci di alcuni dei protagonisti. Antonino Caleca, già Consigliere di Stato laico del C.G.A.R.S., autore della relazione sulla responsabilità degli amministratori locali, ha sottolineato come oggi gli amministratori locali siano soggetti con un eccesso di responsabilità, civile, penale, erariale, alla luce di una considerazione a monte, che “cioè che l’amministratore locale viene vissuto ancora oggi come il soggetto che fa il bene comune solo se la legge glielo impone; se la legge non glielo imponesse, l’amministratore farebbe il suo bene, non quello comune. Questo è un principio che deve essere superato” ed ha citato la legge del 2023 che per la prima volta si rivolge agli amministratori anche a quelli locali con grande fiducia, e che invita a raggiungere il risultato come principale obbiettivo, non un mero formale rispetto della legge: “non è la paura e la punizione che deve guidare l’amministratore ma la volontà di fare il bene pubblico”. Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Consigliere centrale UGCI, ha sottolineato il valore della prevenzione, sia dal punto di vista delle piattaforme digitali, con la responsabilizzazione delle stesse, sia di noi tutti utenti finali, ed ha posto l’accento sull’urgenza della formazione dei più deboli: “Più tutti quanti noi, adulti e minori, siamo consapevoli del fatto di non immettere con un nostro click nell’autostrada del web i nostri dati personali, tanto più ci accostiamo ad una sorta di “cittadinanza digitale” soprattutto da parte dei minori che sono ovviamente i soggetti più vulnerabili al riguardo. Comunque, centrale, essenziale, il momento della preparazione, della formazione, che attraverso le famiglie prima ma poi attraverso la scuola sia fatta nei confronti dei minori perché si accostino a questi strumenti senza demonizzarli ma con la consapevolezza di un utilizzo maturo degli stessi, ripeto, consapevoli dei rischi per cui si va incontro al riguardo”. Alberto Gambino, Prorettore Vicario all’Università degli Studi Europei di Roma, Consigliere Centrale UGCI, ha posto in luce come nell’ambito dei danni, alla persona e patrimoniali, ci sia sempre una frattura sociale cioè una rottura di una convivenza con soggetti che magari non si conoscono ma che con i quali si divide un percorso dentro una comunità: “quindi è importante che anche in un convegno dove si parla di giustizia e responsabilità si ricordi che anche i danni patrimoniali non sono soltanto un momento di compensazione di queste lesioni di diritti economici ma sono anch’essi un momento di recupero di una frattura sociale che altrimenti rimane inevasa e in particolare crea frizioni tra i consociati. Tante volte il risarcimento del danno patrimoniale è molto più efficace di una pena detentiva”. Guido Corso, emerito di Diritto amministrativo all’Università degli Studi Roma Tre, ha affrontato il tema della responsabilità dei funzionari e degli impiegati pubblici e si è soffermato sulla “ripartizione” di questa responsabilità: “il punto focale è che mentre l’amministrazione risponde pienamente qualunque sia il grado di colpevolezza quindi o dolo o colpa grave o colpa lieve, le persone fisiche rispondono solo per dolo o colpa grave cioè dire per evitare che l’amministrazione sia paralizzata dal timore, dal rischio di incorrere in responsabilità si esonera la gente che agisce per l’amministrazione della responsabilità per colpa lieve”. Elisa Scotti, Ordinario di Diritto amministrativo all’Università degli Studi di Macerata, ha richiamato l’importanza dell’Enciclica Laudato sì di Papa Francesco ed ha commentato: “Il diritto spesso arranca: è un diritto mite, un diritto dello sviluppo innanzitutto più che della sostenibilità e nelle maglie della mitezza di questo diritto gli interessi economici hanno la possibilità di intervenire lecitamente trasformando il mondo senza considerare un’istanza integrale di sostenibilità”. Ermanno de Francisco, Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, in un breve intervento non programmato si è soffermato sulla responsabilità etico-morale del giudice il quale è parte di un potere dello Stato, il giudiziario, che è l’unico dei tre poteri che diversamente da legislativo e dall’esecutivo non ha nessuna connessione diretta con la sovranità popolare e ha sottolineato: “Quando dalla nomofilachia, cioè la corretta interpretazione della norma, si passa alla nomopoiesi, cioè la creazione della norma, secondo me il giudice travalica il suo limite” . Alessandro Colavecchio Ordinario di Diritto Amministrativo all’Università degli Studi di Foggia, parlando di responsabilità in ambito energetico, ha chiarito la novità del tema in quanto non vi è una definizione giuridica di responsabilità energetica né tantomeno una disciplina unitaria “e tuttavia questo concetto è dato per presupposto, per implicito, e si trova diffuso a livello di normativa sia nazionale che sovranazionale” aggiungendo “Sicuramente dal punto di vista della amministrativista e più in generale dal punto di vista del giuspubblicista e aggiungerei in particolare del giurista cattolico, una particolare rilevanza nella definizione di questo concetto deve essere attribuita ai doveri di solidarietà economica e sociale espressi dall’articolo due della Costituzione che essendo una clausola di carattere aperto consente di includere al suo interno, soprattutto nella prospettiva della transizione energetica, una serie di doveri a carico non solo dei pubblici poteri ma anche di cittadini e imprese verso comportamenti e scelte energetiche che consentendo l’uso efficiente delle risorse energetiche le rendano disponibili per una platea che sia la più estesa possibile, anche se non soprattutto a favore delle generazioni future”.