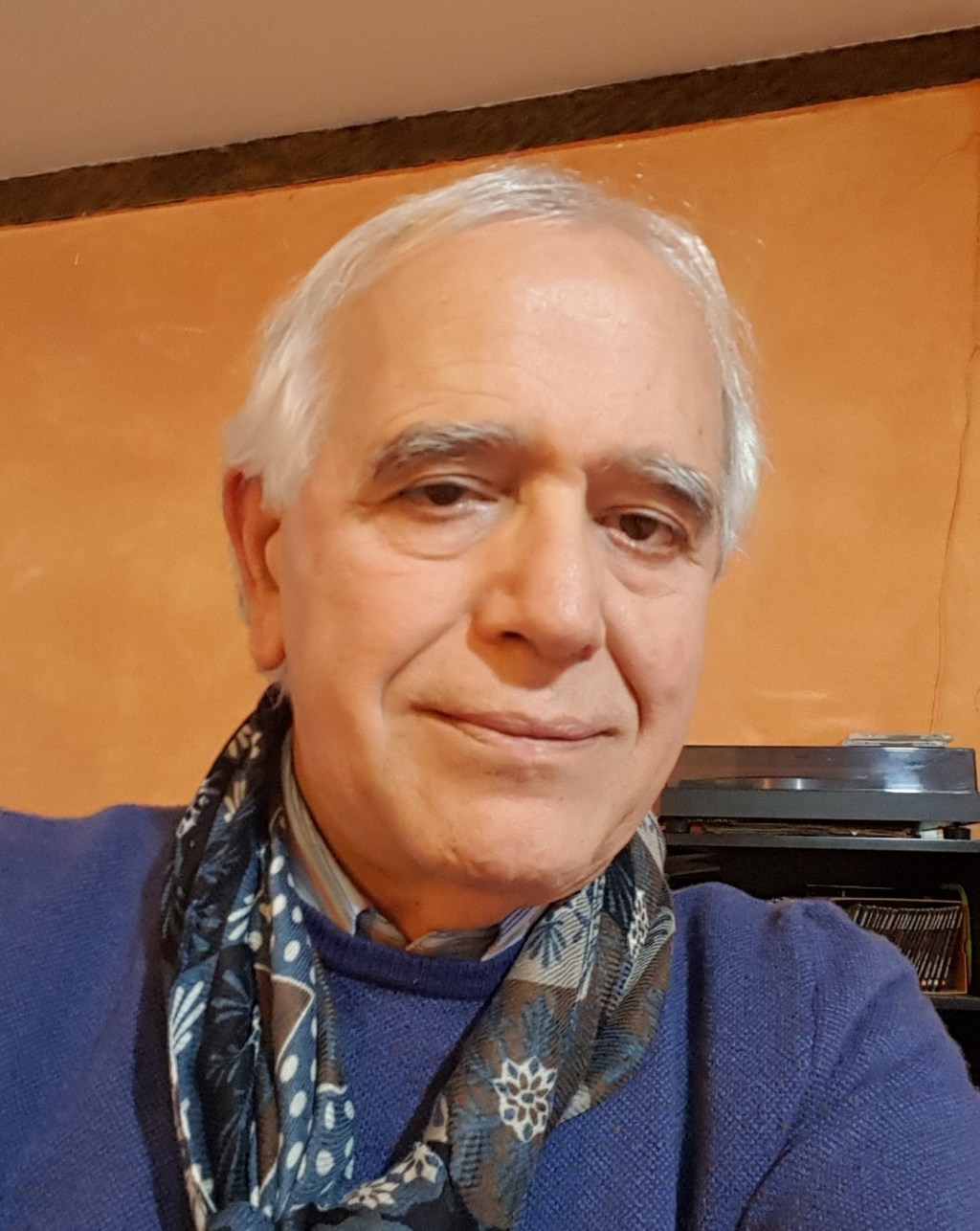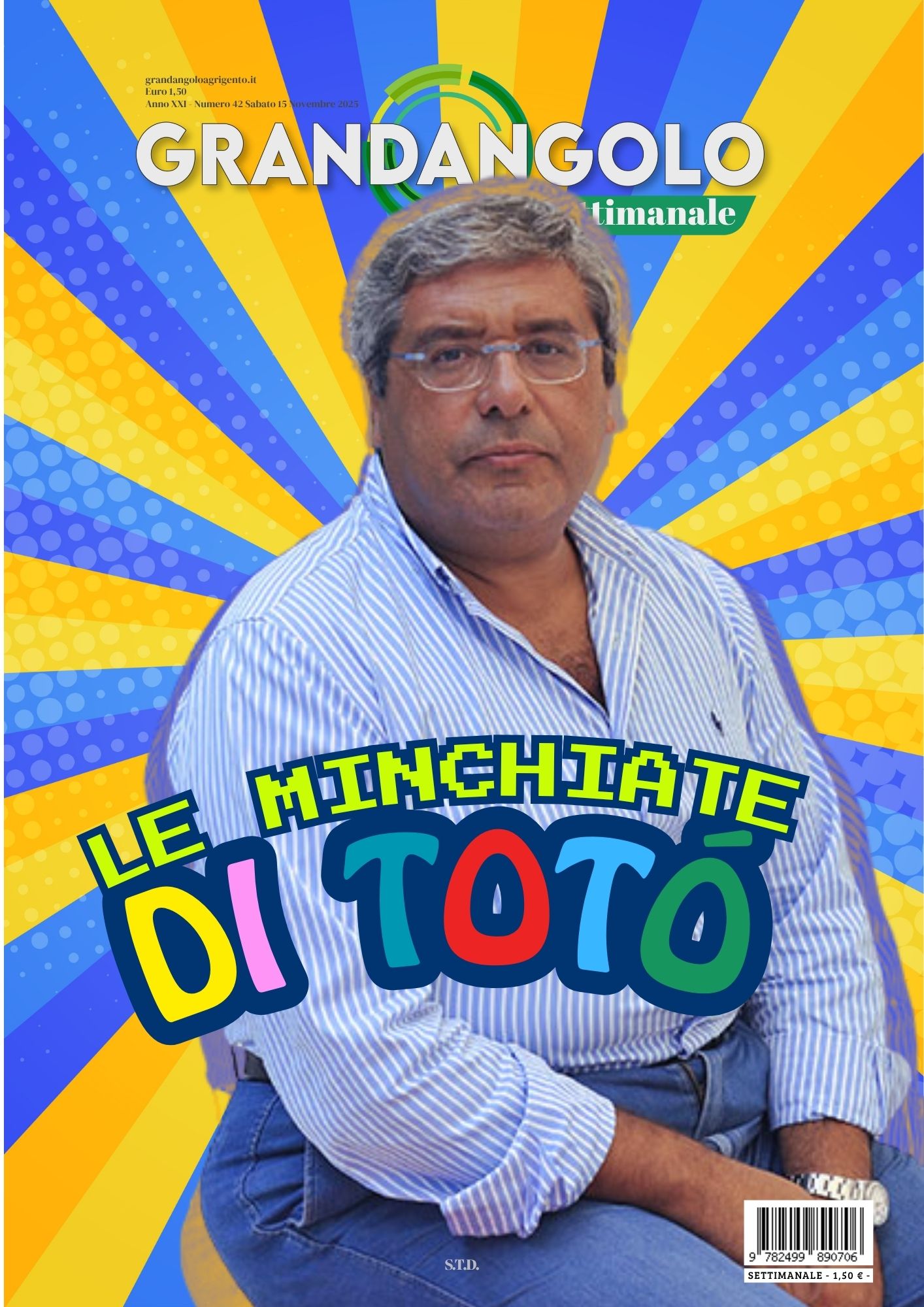L’attualità di Dante Alighieri
di Antonio Liotta
Definire, discutere, analizzare l’attualità di Dante Alighieri porta a ragionare su ciò che si considera un classico.
E’ un tema scottante, in continua evoluzione che risente l’influenza di diverse componenti storiche, sociali e culturali. Per semplificare mi attengo al pensiero di Eliot che riconosce il “classico assoluto” in Virgilio, il poeta che – appunto secondo Eliot – ha costruito un modello punto di riferimento e misura per tutta la letteratura europea considerato anche “garanzia della stessa ‘libertà’ della cultura e della stessa ‘difesa della libertà contro il caos’”.
Lo stretto legame culturale che mi porta ad Italo Calvino, mi permette di condividere alcuni dei 14 punti che lui elenca in definizione di un classico: a) Chiamasi classico un libro che si configura come equivalente dellʹuniverso, al pari degli antichi talismani; b) I classici sono libri che esercitano unʹinfluenza particolare sia quando sʹimpongono come indimenticabili, sia quando si nascondono nelle pieghe della memoria mimetizzandosi da inconscio collettivo o individuale; c) Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire.Un classico, in definitiva, è storia, memoria, etica, eterna attualità, ha sempre qualcosa di nuovo da dire.
E qui pongo la domanda: Dante, dopo settecento anni, ha finito di dire quello che ha da dire?
La realtà è visibile e, senza paura di sbagliare, possiamo affermare che Dante è attuale e che non ha mai finito di esserlo. E partendo dalla riflessione di Eliot, sappiamo che, nella Commedia, è proprio Virgilio che accompagna e guida Dante lungo il percorso dell’Inferno. Una linea di continuità che Dante segue perché sicuramente aveva chiaro il valore dell’autore dell’Eneide e ne riconosce il modello culturale.
L’attualità di Dante sta nella sua modernità di pensiero e di scrittura.
La sua capacità di pensare ed agire è dimostrata da quello che possiamo definire “impegno intellettuale e politico”. Vive l’esilio a difesa delle proprie idee, porta avanti il progetto linguistico unificante dell’intero Paese partendo dalla Scuola siciliana e guarda alle lungimiranti normative di Federico II e di Manfredi quale modello organizzativo politico, sociale e culturale.
La Sicilia è presente in Dante in forma piena. Il De vulgari eloquentiadimostra la spiccata coscienza che Dante ha dell’identità italiana in ordine di unità linguistica, politica, etica. Dante ha denunziato gli effetti negativi e disastrosi a cui porta una politica non incentrata sulla giustizia che inevitabilmente sarà destinata a decadere in demagogia. In questa ottica un preciso riferimento lo troviamo nel VI Canto (verso 76) «nave sanza nocchiere in gran tempesta», tema che fa tuttora riflettere, dopo sette secoli, “sui pericoli cui va incontro una società priva di una guida capace di governare nel rispetto della libertà e della dignità umana. Egoismo, avidità, idolatria del potere e della ricchezza, sovvertimento dell’ordine naturale: sono questi i mali che finiscono con l’affliggere una società smarrita.”
E Dante pone la necessità di garantire e realizzare: laicità con la separazione dei poteri temporale e spirituale, e partecipazione politica.
Dante pensava, diversamente da molti uomini del suo tempo, che il potere dell’imperatore non dipendesse dal potere papale, ma discendesse direttamente da Dio.
Per rendere questi concetti chiari, pensiamo al III Canto dell’Inferno, a come vengono trattati gli ignavi – o meglio le loro anime – costretti, nell’applicazione di un preciso contrappasso, a inseguire un’insegna bianca priva di significato. Anime ignorate, senza storia che Dante colloca nell’Antinferno proprio per la loro insensibilità e partecipazione alle varie forme di interesse politico e religioso.
Il giudizio di Dante per coloro che in vita si sottraggono agli impegni e alle responsabilità legate all’esistenza umana e al vivere sociale, nasce anche dal fatto che il nostro sommo poeta apprezza e cerca di affermare il grande “dono del libero arbitrio fatto da Dio all’uomo quale più alta testimonianza del suo amore e della sua fedeltà.”
L’attualità del pensiero di Dante è legata, in forma dominante, alla evidente trasmissione dell’universale messaggio di onestà, di giustizia e di fraternità che sgorga dalle sue opere e in modo particolare dalla Divina commedia. Le sue pagine sono “cariche di valori, di umanità, di esortazione a non perdersi dietro false felicità e di non rinchiudersi nella gabbia dell’egoismo, ma di coltivare il rispetto per l’altro, nel perseguimento della pace e della giustizia”.
Nella realtà di oggi liquida e sfuggente di baumaniana memoria, dove vincono i nuovi vizi/peccati capitali superficialità, consumismo, individualismo, conformismo o omologazione, sessomania, spudoratezza, sociopatia, diniego o negazionismo, vuoto, bulimia e anoressia e bullismo,in questa “società a scadenza breve” (come mi permetto di definirla) i valori danteschi sono punti fermi da cui partire per costruire una società consapevole e democratica attraverso una sintesi intellettuale capace di integrare applicazioni e compromissioni legate fortemente alla realtà ma intrise e nutrite di etica. Altro aspetto che ci deve fare riflettere: la modernità del linguaggio.
Dante ha una narrazione che si auto-completa in ogni storia affrontata, ma si sviluppa ed intreccia e finalizza alla storia nella sua completezza. È fortemente visiva e racconta per immagini.
In conclusione: dove risiede la sua profonda attualità? Sicuramente nella misura in cui l’opera di Dante – ed in particolare la Commedia – è recepita come una delle più alte realizzazioni dello spirito umano. Per tutto quanto premesso la Commedia è un classico assoluto.
E torniamo a Calvino che chiudendo la sua proposta di definizione di classico cita Emil Cioran: “Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate stava imparando unʹaria sul flauto. «A cosa ti servirà?» gli fu chiesto. «A sapere questʹaria prima di morire».
Dante ci aiuta sempre di più ad imparare il nuovo sapere.