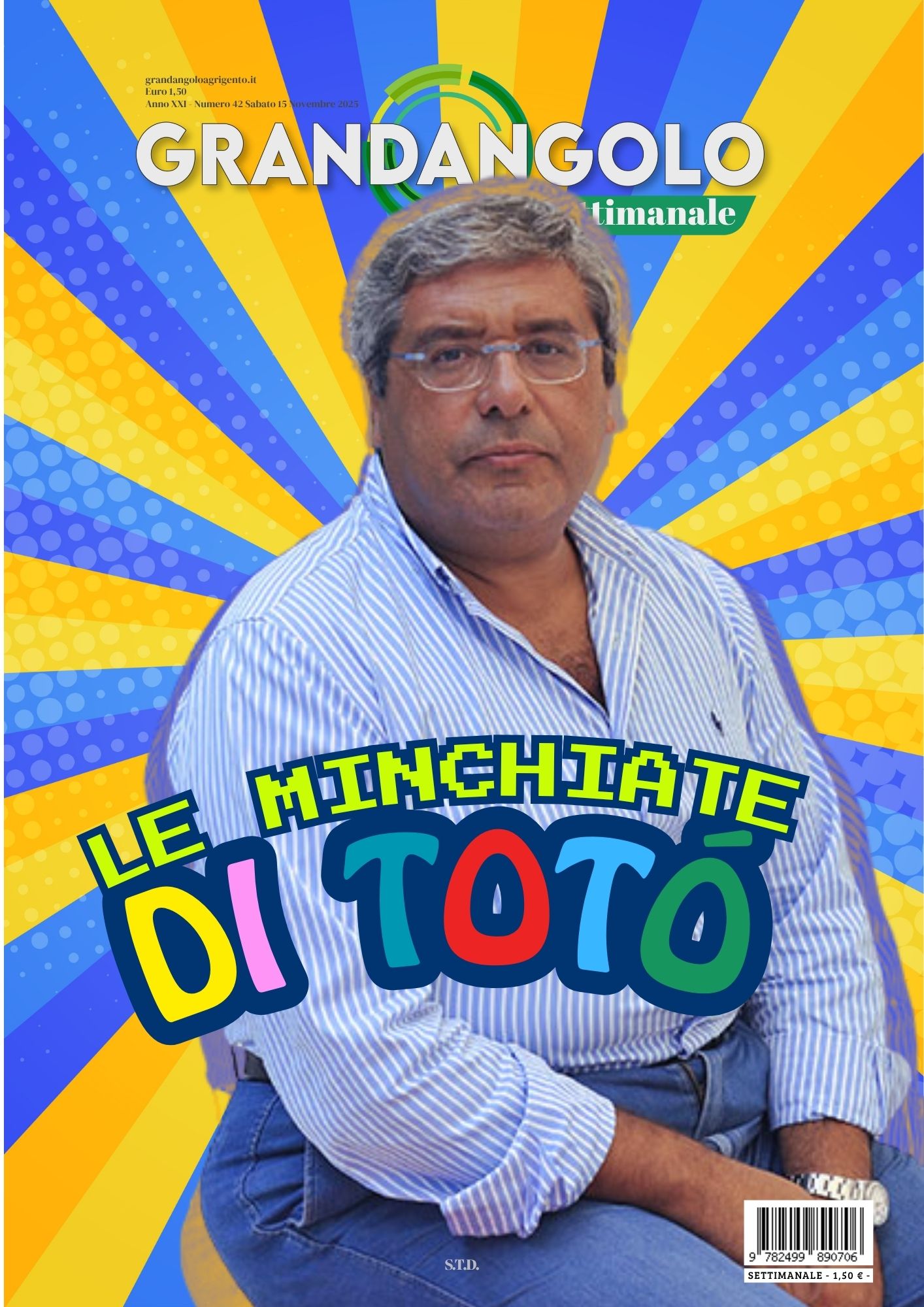Mafia, Rosario Livatino: trent’anni dopo il suo martirio
di Salvatore Cardinale. La mattina del 21 settembre 1990, alle porte di Agrigento, cadeva in un agguato mortale Rosario Angelo Livatino, giudice nativo di Canicattì in servizio al Tribunale di Agrigento. Veniva ucciso da un gruppo di giovani assassini affiliati all’associazione para-mafiosa “Stidda” mentre, come di consueto, alla guida della sua autovettura si avviava da […]
di Salvatore Cardinale.
La mattina del 21 settembre 1990, alle porte di Agrigento, cadeva in un agguato mortale Rosario Angelo Livatino, giudice nativo di Canicattì in servizio al Tribunale di Agrigento.
Veniva ucciso da un gruppo di giovani assassini affiliati all’associazione para-mafiosa “Stidda” mentre, come di consueto, alla guida della sua autovettura si avviava da solo e senza scorta per raggiungere la sede del suo ufficio.
Sono trascorsi trent’anni da quel tragico avvenimento ma è sempre vivo il doloroso ricordo della morte del magistrato, onorato da un cippo elevato sul luogo dell’assassinio e commemorato con una stele posta all’interno della Valle dei templi di Agrigento, al pari di altri “Giusti dell’umanità”, anch’essi celebrati per il loro amore verso la Giustizia.
Due anni prima nel medesimo mese di settembre e sulla medesima strada statale, oggi denominata la “Strada degli scrittori” in memoria di illustri personalità del mondo letterario delle province di Agrigento e Caltanissetta, erano stati uccisi da un commando mafioso il giudice Antonino Saetta e, vittima innocente, il figlio Stefano che l’accompagnava. Il Presidente Saetta era stato eliminato per impedirgli di presiedere a Palermo, in secondo grado, il c.d. Maxiprocesso contro le cosche mafiose e i loro affiliati.
Sono due omicidi che, seppur consumati in luoghi, tempi e contesti diversi, hanno, a parte la comune origine canicattinese e la medesima funzione giudiziaria giudicante delle vittime, un denominatore unico: il martirio, inteso – come indicava Giovanni Paolo II – quale testimonianza della “grande causa di Dio”.
Una recente scuola di pensiero, della quale si è fatto portavoce un esponente politico siciliano, figlio di un assassinato dalla mafia, ritiene che non sia più tempo di commemorazione e che bisogna “guardare avanti”.
Mi piace rispondere a tale autorevole, ma non condivisa, presa di posizione con le parole di una giornalista la quale sul quotidiano “Il Giornale di Sicilia”, commentando altro anniversario, la morte di Libero Grassi, ha scritto che “la celebrazione del ricordo non è un processo individuale. Perché anche la comunità ha bisogno di una memoria collettiva di tutti i riti che mantengono vivo ciò che altrimenti cadrebbe nell’oblio. Vietato dimenticare perché se la mafia uccide, il silenzio pure” (Giusi Parisi, “Libero Grassi , in strada contro il silenzio”. Giornale di Sicilia del 30.agosto 2020).
Rosario Livatino era nato a Canicattì il 3 ottobre 1952. Apparteneva, per nascita e censo, alla borghesia del suo paese ma tale sua origine agiata non condizionerà mai la sua attività di magistrato essendo state l’imparzialità e l’indipendenza i connotati unici del suo operare e della sua fede nell’alto compito del giudicare.
Terminato brillantemente il corso di studi universitari, Rosario Livatino, dopo una breve esperienza lavorativa presso l’Amministrazione finanziaria statale, superava il concorso in magistratura e, esaurito il prescritto tirocinio presso la Corte di Appello di Caltanissetta, il 29 settembre 1979 assumeva servizio, come prima sede di lavoro, presso la Procura della Repubblica di Agrigento, ove operava per molti anni finché, nel 1989, sceglieva di arricchire la sua formazione professionale sperimentando le funzioni giudicanti.
Nell’incarico di magistrato requirente, egli dimostrava tutti i positivi caratteri della sua personalità: profonda cultura generale e aggiornata cultura giuridica, tenacia nelle indagini, indipendenza da qualsiasi forma di condizionamento, equilibrio nella valutazione delle prove, dialogo con le Forze dell’ordine, interazione fattiva con i colleghi, coinvolgimento operoso dell’apparato amministrativo giudiziario, rispetto verso l’Avvocatura.
Nel lungo periodo, era chiamato a trattare varie pratiche processuali, a volte molto spinose e impegnative come, tra le tanti, quelle riguardanti due istituti di credito gestiti con metodi familistici e quella sugli allora intoccabili “cavalieri del lavoro“ catanesi, indiziati di una evasione fiscale di notevole entità ottenuta attraverso il metodo truffaldino dell’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti in combutta con personaggi mafiosi, indagine quest’ultima particolarmente delicata per varie ragioni che il Sostituto Procuratore Livatino dirigeva con professionalità, indipendenza e dovuto riserbo.
Egli trattava ogni fascicolo assegnatogli con lo stesso impegno, qualunque fosse l’oggetto di esso. Sollecito nel lavoro, rispettava l’esigenza di rapida conclusione dei fascicoli a lui affidati. Sapeva sostenere le sue ragioni ancorandole a robusti argomenti, prove sicure e pertinenti richiami alla giurisprudenza e per tali ragioni era in grado di ottenere pronunce giudiziarie coerenti con l’approfondito lavoro investigativo compiuto e l’attento studio delle carte.
Rosario Livatino coniugava felicemente la sua cultura giuridica e la sua vita professionale con la fede religiosa di cui era portatore e svelava tale sua modalità di intendere l’amministrazione della giustizia in una sua relazione, che per la tragica fine del suo autore, è affidata ormai alla memoria dei posteri, intitolata “Fede e diritto”. Come annota in un articolo la rivista dei Gesuiti Civiltà Cattolica, Livatino “oltre alla coraggiosa scelta di operare in prima persona per una società più equa e civile, ha saputo coniugare la propria azione professionale con i propri valori e il proprio credo, qualificando la prima nella prospettiva religiosa che egli aveva abbracciato e profondamente coltivato nel suo intimo”.
Egli sapeva ancorare il suo magistero all’attenzione verso la modernità, i cambiamenti, le novità sociali, senza dimenticare i principi morali legati ad una sana tradizione. In proposito, egli scriveva: “il ruolo del giudice non può sfuggire al cambiamento della Storia: tanto egli che il servizio da lui reso devono essere partecipi di un processo di adeguamento”.
Il suo contegno in pubblico era irreprensibile e pienamente confacente alla professione che esercitava la quale richiede, in ogni momento e circostanza, continenza di comportamenti.
Ma, in particolare, ciò che lo contraddistingueva era la coerenza, costante e mai tradita, in tutte le manifestazione della sua vita tra l’essere e l’apparire, un impegno sempre perseguito il cui valore egli spiegava nella sua relazione “Il giudice nella società che cambia” e nell’incipit “il giudice di ogni tempo deve essere ed apparire indipendente”.
Schivo da ogni forma di deleterio protagonismo, manifestava questa sua scelta in ogni occasione della sua vita professionale e privata. Così, conservava gelosamente il segreto istruttorio pretendendone il rispetto anche dai suoi collaboratori, stava lontano da occasioni di rilevanza mediatica, evitava interventi pubblici che potessero dare adito a strumentalizzazioni di ogni genere, manteneva, come fatto privato, il riserbo sulla sua fede e sulla pratica religiosa che viveva senza esteriorità, rifiutava di iscriversi a gruppi o associazioni, ivi compresa l’Associazione di categoria. In poche parole, rifuggiva da manifestazioni o atteggiamenti astrattamente o concretamente idonei ad appannare quell’immagine di terzietà che rappresenta l’essenza dell’essere magistrato.
Nella vita privata selezionava le amicizie e le frequentazioni evitando contatti con persone discutibili, o inserite in contesti di potere e di affari, e tutte quelle situazioni che, comunque, potessero consentire a terzi di sfruttare la relazione amicale per fini privati.
I molti anni di servizio presso la Procura della Repubblica di Agrigento gli consentivano di acquisire una vasta conoscenza della realtà criminale del Circondario e del fenomeno mafioso in particolare che in provincia di Agrigento assume, per nefasta tradizione, connotati peculiari. Notevole era stato l’impegno profuso in un’indagine giudiziaria, denominata “Santa Barbara”, grazie alla quale era disegnata, dopo anni di sterili tentativi investigativi, la mappa delle consorterie criminali associate operanti su vaste zone del territorio provinciale, erano perseguiti capi e gregari di vari clan e erano svelati gli intrecci illeciti tra mafia, imprenditoria, mondo politico e apparati amministrativi territoriali.
Il suo impegno in tale indagine, condotta insieme ad altri colleghi, era assoluto e per niente condizionato dalla circostanza che la lista degli indagati annoverasse personaggi di spicco della “famiglia” mafiosa di Canicattì, espressione di una consolidata tradizione criminale i cui negativi protagonisti di ieri e di oggi avevano goduto e continuano a godere attualmente, nell’universo del crimine organizzato, di ampio potere e di vasta considerazione anche a livello di direttorio regionale per gli stretti e consolidati legami con le consorterie di più rilevante caratura criminale.
Forte di tale patrimonio conoscitivo, dopo molti anni di esercizio di funzioni requirenti, Rosario Livatino accedeva a sua domanda al Tribunale di Agrigento, ove assumeva servizio il 21 agosto 1989, per una nuova esperienza lavorativa che però gli risulterà fatale giacché, a causa del suo notevole bagaglio professionale e di conoscenze che gli consentivano inevitabilmente di eccellere tra i colleghi, diverrà bersaglio d quel progetto omicidiario che, un anno dopo, lo priverà della vita.
La sua uccisione sorprendeva tutti, magistrati e forze dell’ordine in primis che non avevano percepito fino a quel momento segnali di sovraesposizione del giudice né avevano avuto sentore della preparazione di un’azione eversiva di tal genere contro di lui.
Alle domande del perché Rosario Livatino sia stato ucciso e del perché, tra i vari magistrati in servizio al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Agrigento, sia stato scelto proprio lui hanno dato risposta i giudici del Distretto giudiziario di Caltanissetta che, nelle sentenze pronunciate contro gli esecutori e i mandanti dell’omicidio, hanno ricostruito l’evento e fornito una coerente rappresentazione del fatto e dei moventi, offrendo una verità processuale che nel corso degli anni non ha trovato smentita nelle aule giudiziarie, sede naturale nella ricostruzione di ogni avvenimento delittuoso.
Da tali sentenze, si ricava un insieme di fattori che stanno alla base dell’assassinio.
Il movente principale è dato dalla smania di grandezza del nuovo gruppo para-mafioso “Stidda” che, da poco affacciatosi sulla scena del malaffare, per accreditarsi e assumere una posizione di forza nel mondo criminale e in particolare agli occhi della contrapposta organizzazione “Cosa nostra”, sceglie – sulla scia di condotte già sperimentate dai più importanti gruppi mafiosi isolani – un simbolo dello Stato “eccellente” che, peraltro, viaggiava indifeso e rappresentava un facile bersaglio.
Di Livatino magistrato rimangono le sue requisitorie, le sue sentenze e i suoi decreti di prevenzione, documenti sparsi tra i vari fascicoli della Procura della Repubblica e del Tribunale di Agrigento che forse sarebbe opportuno recuperare.
Ma, per conoscere il vero Livatino occorre richiamare le due relazioni che egli ha consegnato ai posteri: “Il ruolo del giudice nella società che cambia” e “Fede e diritto” nelle quali egli espone con compiutezza, convinzione e capacità illustrativa, il suo pensiero su come deve essere il giudice per essere coerente con l’alta missione di giudicare che gli viene affidata e di come il giudice, nell’applicare la legge, non debba fermarsi al dettato freddo della norma ma debba anche essere misericordioso.
La morte è per definizione circostanza triste e dolorosa ma, nei confronti di Rosario Livatino, ha rappresentato lo strumento, certamente tragico e non auspicato, per svelarci il suo vero profilo di uomo, di figlio, di magistrato e di credente: in altri termini, come compiutamente annota don Vincenzo Sorce in un libro dedicato anche alla figura del giudice, per rivelare il ritratto di “un uomo straordinario del nostro tempo e della nostra Sicilia: giudice, educatore di coscienze, presenza inquietante nel mondo della giustizia, coraggioso estirpatore del seme velenoso della mafia. Martire, martire di oggi, martire della giustizia, della carità della fede”.
Lo stesso giorno, il 9 maggio 1993, in cui nella Valle dei templi di Agrigento lanciava il suo celebre anatema contro i mafiosi, il papa Giovanni Paolo II definiva Rosario Livatino “martire della giustizia e, indirettamente, della fede”.
Al Convegno ecclesiale di Verona, svoltosi nell’ottobre 2006, Livatino è stato proposto come testimone credibile della Regione ecclesiastica Sicula e, a conclusione dei lavori, è stato indicato dai convegnisti come espressione di santità di oggi per il modo in cui ha vissuto la sua breve e intensa vita e si è posto quale sfida al male, all’odio e alla violenza di cui la mafia si nutre.
Come aveva rilevato anni prima l’arcivescovo di Agrigento mons. Carmelo Ferraro, uccidendo Rosario Livatino, “gli assassini, senza saperlo, anziché spegnere quella luce, hanno acceso un’enorme fiaccola”.
Sono stati i primi passi verso l’inizio di quel percorso liturgico di canonizzazione che, iniziato il 21 settembre 2011 e concluso recentemente con l’inoltro degli atti alla Congregazione per le cause dei Santi, potrebbe portare Rosario Livatino agli onori dell’altare e della devozione popolare come già è avvenuto per il suo concittadino Padre Gioacchino La Lomia e per gli altri santi venerati della gloriosa Chiesa Agrigentina che l’hanno preceduto.
Qualunque sarà l’esito del processo liturgico, l’assassinio di Rosario Livatino ha un suo specifico denominatore: il martirio, inteso – come indicava Giovanni Paolo II – quale testimonianza della “grande causa di Dio” e riscatta la Sicilia affrancandola dal solito negativo stereotipo di terra di mafia e di sangue per presentarla al mondo nella nuova immagine di “terra di martiri”, vale a dire ”terra di futuro e speranza”.
Ma la figura di Rosario Livatino ha coinvolto anche il mondo laico che vede nel giudice ucciso la rappresentazione più fedele della figura del magistrato indipendente, imparziale e terzo.
A Rosario Livatino sono dedicati studi, lavori cinematografici, libri, servizi televisivi che ne esaltano la personalità e i tratti salienti della sua breve vita.
Anche il mondo della scuola mostra ammirata attenzione verso il giudice facendone oggetto di studio da parte degli studenti e proponendolo quale esempio di rettitudine e professionalità..
Al suo nome vari comuni e istituti scolastici hanno intitolato vie, scuole, biblioteche, palestre ed altri edifici pubblici quali testimonianza di un ricordo che non va perduto.
Ecco perchè oggi, a distanza di trent’anni da quella tragica morte, la società è chiamata al dovere di ricordare ancora una volta il sacrificio di Rosario Livatino.